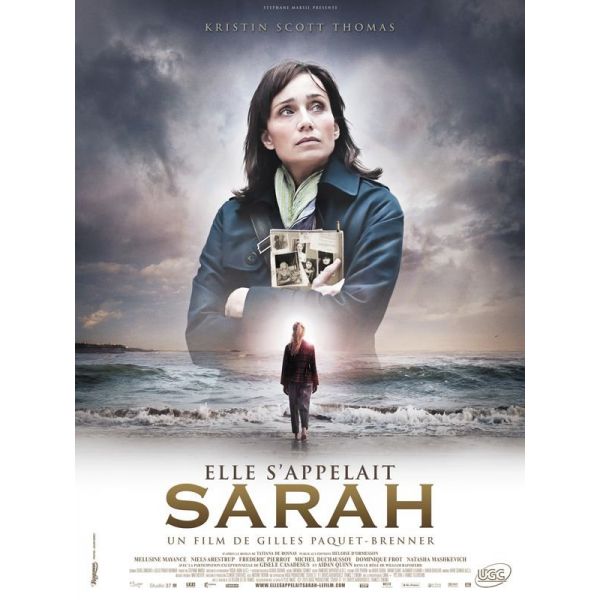Abstract – scaricare il file per l´appunto completo
Sommario Italiano: G. D’Annunzio Filosofia: F. Nietzsche Storia: La prima guerra mondiale Fisica: La Fisica dall’800 al ‘900 Inglese: Science Fiction stories Italiano: Gabriele DAnnunzio La vita Nato nel 1863 a Pescara, da agiata famiglia borghese, studiò in una delle scuole più aristocratiche del tempo. A soli 16 anni esordì con Primo vere un libretto in versi. A 18 anni si trasferì a Roma, dove abbandonò gli studi per la vita mondana. E qui che iniziò per lui una più brillante avventura letteraria ed, insieme, umana. Egli fu per anni cronista mondano dellaristocrazia della capitale e simmerse in una vita desteta, protesa fra amori e avventure e alla ricerca di piaceri raffinati: divenne famoso per la vita e le opere scandalose, creandosi la maschera dellindividuo superiore che rifugge dalla mediocrità, rifugiandosi in un mondo di pura arte che ha come regola di vita solo il bello e la ricerca dellerotismo, ideale sulla base del quale si sforzerà continuamente di costruire una concezione della vita. Il rapporto strettissimo tra arte e vita lo porterà a realizzare opere darte come forme di vita e a “vivere la vita come unopera darte”. Nei primi anni del 90 però DAnnunzio entrò in crisi, una sorta di crisi dovuta ad una stanchezza dei sensi dopo lorgia voluttuosa di piacere e di mondanità. Tale crisi non fu però spiritualmente tanto profonda: segnò solo il passaggio dal primitivo estetismo a una diversa mitologia, quella appunto del superuomo. Si trattava di una variante del del sensualismo e dellestetismo dannunziani ispirata ad una adesione superficiale alle teorie del filosofo tedesco Nietzsche: dellesaltazione, cioè della volontà di potenza di creature privilegiate, intese a costruirsi una vita inimitabile, sempre sopra le righe, mai banale, come quella a cui tendeva lestetismo, ma con, in più, una marcata volontà di affermazione nel mondo. Egli non accetta di essere una persona qualunque, il poeta vuole essere qualcuno, vuole lasciare unindelebile traccia della sua esistenza: ciò richiama le tesi fondamentali del mito del superuomo, apprese da DAnnunzio in maniera semplice e indiretta attraverso la mediazione degli spettacoli di Wagner. Egli puntava al vivere inimitabile. D’Annunzio condusse una vita da principe rinascimentale nella villa di Fiesole, tra oggetti darte, amori lunghi e tormentati (Eleonora Duse), con un dispendio di denaro che egli non riusciva a controllare. Proprio questa fu la contraddizione che non riuscì a superare: egli disprezzava il denaro borghese, ma non poteva farne a meno per la sua vita lussuosa. Proprio per limmagine mitica che voleva dare di sé, tentò anche lavventura politica, anche se in un modo ambiguo, schierandosi prima con la destra e poi con la sinistra. In seguito rivolse la sua attenzione anche al teatro, poiché poteva raggiungere un pubblico più vasto rispetto ai libri. Ma nonostante la sua fama fosse alle stelle ed il dannunzianesimo stesse improntando tutto il costume dellItalia borghese, DAnnunzio, a causa dei creditori, dovette fuggire dallItalia rifugiandosi in Francia. Loccasione tanto attesa per lazione eroica gli fu offerta dalla I guerra mondiale. Allo scoppio del primo conflitto mondiale DAnnunzio tornò in Italia ed iniziò una campagna interventista. Arruolandosi volontario fece imprese clamorose e combattè una guerra eccezionale non in trincea, ma nei cieli con il nuovissimo mezzo: laereo. Nel dopoguerra capeggiò una marcia di volontari su Fiume dove instaurò un dominio personale. Cacciato via, sperò di riproporsi come duce di una rivoluzione reazionaria ma fu scalzato da Mussolini. Il Fascismo lo esaltò come padre della Patria ma lo guardò anche con sospetto confinandolo nel Vittoriale degli Italiani, una villa di Gardone, che egli trasformò in vero mausoleo. Qui trascorse gli ultimi anni fino alla morte avvenuta il 1° marzo 1938 per una emorragia celebrale. Linfluenza di DAnnunzio sulle cultura e sulla società fu lunga ed importante, lasciando unimpronta sul costume degli italiani e sulle nascente cultura di massa. A causa delle sue sperimentazioni superomistiche in ambito politico divenne celebratore di se stesso e con lui tramontò definitivamente la figura del poeta-vate, compromessa da una avventura storica che ne aveva bruciato la credibilità. Gli elementi che caratterizzano la personalità letteraria dannunziana sono: il Superomismo; lEstetismo; il Sensualismo; lEgocentrismo Il Superomismo come accennato precedentemente rappresenta latteggiamento di superiorità dannunziano, al di sopra del bene e del male. A differenza di Nietzsche, DAnnunzio proclama la necessità di una vita in perpetua ascensione (Superuomo dannunziano) per un impulso costante di quegli elementi che DAnnunzio chiama La Quadriga Imperiale della sua anima, il cocchio dellanima eroica. Il suo slancio superomistico lo porta ad una immediata comunione con la natura e con le sue forze elementari. In questo egli intravede una felicità che coincide con una vita avventurosa ed eroica; la fusione di Volontà e Voluttà (cioè il piacere) e di Orgoglio e Istinto (la quadriga imperiale appunto) permette di diventare tuttuno con lenergia creatrice della natura, di continuarla, anzi, di emularla. Il concetto chiave del superomismo dannunziano è contenuto nel primo libro delle Laudi, Maia o Laus Vitae (Inno alla vita) una autentica celebrazione dell’energia vitale; un naturalismo pagano impreziosito dai riferimenti classici e mitologici. In essa viene ribadito la concezione del superuomo come persona al di sopra di tutto, ed inoltre spiega la sua volontà di vivere intensamente la sua vita, giorno per giorno. Nulla gli è estraneo e lontano e sconosciuto, finche vivrà. La sua anima vive quanto altre diecimila e non si ferma dinanzi a nulla. E attratto da tutto e vuole possedere ogni cosa. A tutto ambì e tutto tentò, quello che non fu fatto lo sognò, ma il sogno fu talmente intenso che eguagliò latto. Ne Le vergini delle Rocce del 1895 si nota una profonda politica antidemocratica ed un ritorno ai modelli Romani: la complessità superomistica subisce una sostanziale semplificazione nella direzione di un superomismo a impronta esclusivamente estetica che sintride di valenze politiche reazionarie. Lopera narra appunto di un giovane romano, Claudio Cantelmo, sdegnoso della realtà borghese e resosi conto della situazione romana (venti di barbarie dice DAnnunzio riferendosi ai nemici dellarte ai quali oppone la figura di Cantelmo) cerca in un vano tentativo di dare alla luce una creatura eletta, che sarà capace di risollevare le sorti di Roma, ma per realizzare ciò egli doveva necessariamente scegliere una genitrice allaltezza del compito. La scelta doveva essere fatta tra tre giovani (le vergini delle rocce), sulle quali però incombeva un oscuro destino familiare: alla fine tutte e tre si riveleranno inadatte al compito e Cantelmo dovrà rinunciare al suo sogno di dare alla vita un Superuomo che avrebbe dovuto coprire il ruolo di futuro Re di Roma e dItalia. Il vero protagonista dellopera è lo stile che fa da cornice alle idee superomistiche precedentemente esposte. LEstetismo trattato precedentemente, rappresenta il fulcro della poesia dannunziana, la fonte ispiratrice e di vita per lo stesso autore, tanto che, come già accennato, sulla base di esso fondò la sua intera esistenza. Lespressione estetica corrispondente in qualche modo al romanzo A rebours di Huysmans confluisce nellopera estetica più rappresentativa di DAnnunzio: Il Piacere (nel quale rintracciamo degli ovvi riferimenti con la voluttà e lestetismo, capisaldi dannunziani). Il romanzo del 1889 vede protagonista Andrea Sperelli, il doppio di DAnnunzio stesso; è un giovane aristocratico ed il principio fare la propria vita, come si fa unopera darte diviene una forza distruttiva. La crisi è molto evidente nel suo rapporto con le donne: è diviso fra due donne Elena, la donna fatale e Maria, quella pura. Ma lesteta mente a sé stesso: la figura della donna angelo è solo oggetto di un gioco erotico sottile e perverso, e funge da sostituto di Elena, che Andrea desidera ma lei essa rifiuta. Infine viene abbandonato da entrambe, in particolare da Maria quando dubbiosa riguardo la sincerità di Andrea e la veridicità dell’amore nei suoi confronti, ottiene la certezza di ciò quando, per sbaglio, Andrea la chiama Elena. Il romanzo pur essendo monotono e non rappresentando la massima espressione artistica di DAnnunzio ebbe grande successo più che per ragioni artistiche, appunto, per ragioni sociologiche, poiché interpretava le esigenze di certo gusto contemporaneo. Alla base di tutto possiamo quindi sottolineare Il culto dellArte per larte, lidentificazione del ruolo dellartista con quello di un sacerdote di pura bellezza, senza preoccupazioni morali. DAnnunzio afferma che larte si spiega con larte. Ed è qesta la differenza con Pascoli, poiché quest’ultimo considera l’arte (ricca di fini morali) istigatrice di buoni costumi. A volte lestetismo mostra i suoi lati peggiori ed in certe situazioni può disgustare per brutalità e per mistura blasfema di religione e lussuria, ma a volte si carica di autentico patos e si identifica con lanima stessa della poesia. Estetismo – Superomismo – Il suo Estetismo, in seguito, si unirà con laltro elemento costituente di gran lunga la letteratura dannunziana: il superomismo. Da questa unione feconda DAnnunzio si operò a fornire un nuovo tipo di estetismo che non fosse solo professione mondana, ma gesto, impresa, avventura. Ed è proprio l’unione di questi due aspetti fondamentali che contribuisce all’esaltazione del proprio io dannunziano. Comune ad ambedue è l’esaltazione di quella che il poeta chiamò, come detto poc’anzi, la “quadriga imperiale” della sua anima, cioè l’unione di voluttà e istinto, orgoglio e volontà, anche se i due ultimi termini sono propri, soprattutto dell’esperienza “superumana”. Il Sensualismo è celebrato da DAnnunzio in tutti i suoi aspetti poiché convinto che il senso e non lintelletto sia lo strumento infallibile della conoscenza. Il dominio del mondo è per lui possibile soltanto con il senso. In fondo l’erotismo e il superomismo rappresentano i due aspetti concomitanti dell’aspirazione sensuale del D’Annunzio (alludendo non tanto al carattere erotico di molte sue produzioni, quanto invece al suo rifiuto della razionalità e della storia, in nome della suggestione sensoriale menzionata poc’anzi). Nellerotismo il senso è caratterizzato dal desiderio e dallorgiastico. Lerotismo a lungo andare genera sazietà e così DAnnunzio esprime la stanchezza e il disgusto dei sensi e laspirazione ad una vita sana ed innocente (o addirittura alla rinuncia ascetica). E facile intuire che questi momenti di rinuncia durino molto poco per DAnnunzio, ed un esempio di ciò ci viene fornito dalla poesia I Pastori nella quale egli dichiara di invidiare la vita svolta dai pastori della sua terra ed inoltre di desiderare ardentemente di poter emulare lui stesso le gesta cantate nella poesia (ad esempio il rito della transumanza). Di sottile erotismo è permeato anche il suo particolare gusto per la parola ed il Flora dice: DAnnunzio accarezza le parole come se fossero cose vive, anzi donne. LEgocentrismo dannunziano poneva il proprio io al centro del mondo, avanzando così anche qualche rifacimento al Narcisismo, anzi rappresentando la punta avanzata del Narcisismo decadente con il quale avanzava l’idea di identità Io-Mondo. Cronologia e Opere · 1863 Nasce a Pescara il 12 marzo. · 1874 Viene iscritto al collegio Cicognini di Prato, dove resta sino al completamento degli studi liceali (1881). · 1879 Pubblica una raccolta in ve (segue nel file da scaricare)
- Tesine