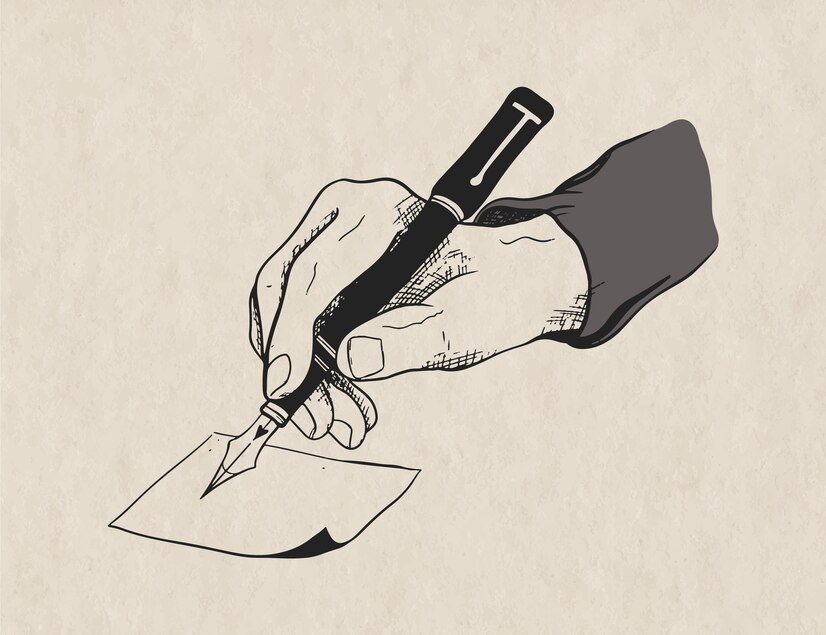La casa in collina venne pubblicato assieme ad un altro romanzo breve, Il carcere, nel 1949 e sotto il titolo di Prima che il gallo canti. L’accostamento delle due opere non era casuale: l’intreccio di due solitudini, il bilancio della propria essenza esistenziale, il tradimento e forse l’autoassoluzione per non aver partecipato attivamente alla lotta resistenziale. In entrambi i romanzi è presente una sorta di prigione, i cui confini sono disegnati dal mare ne Il Carcere e dalla collina nel romanzo La casa in collina. Là Stefano, confinato ed esule in un mondo primitivo che si fa mito, qua Corrado, fuggiasco, che cerca nella meditazione e nel rapporto con l’osteria Alle Fontane un senso al suo forse non scelto disimpegno.
«Gia in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare o la boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava, e per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, un modo di vivere.(…) Si prendeva la salita,e ciascuno parlava della città condannata,della notte e dei terrori imminenti (…). Devo dire- cominciando questa storia di una lunga illusione- che la colpa di quel che mi accadde non va data alla guerra. Anzi la guerra,ne sono certo,potrebbe ancora salvarmi.(…). La guerra mi tolse soltanto l’estremo scrupolo di starmene solo, di mangiarmi da solo gli anni e il cuore, e un bel giorno mi accorsi che Belbo, il grosso cane, era l’ultimo confidente sincero che mi restava».
Elena ne Il Carcere ed Elvira ne La casa in collina sono rispettivamente le due donne che lo amano, che lo ammirano, subendo il fascino della sua cultura e del suo intellettualismo aristocratico, che sono disposte ad aspettare che egli le scelga e che, invece, lui o disprezza o ignora: emblema inquietante di quella misoginia malamente mascherata, di quella disperata ricerca di amore che invece non c’era, nella sua vita, e forse non ci sarebbe stata mai.
Non è facile nascondere a Pavese la sua tendenza all’autobiografia, sia pure celata dietro inutili artifici: professore di scienze, Corrado, e non di letteratura, ma appunto l’espediente serve a poco e del resto poco importava, poco importa. Cesare/Corrado vuole narrare la guerra come idea, come impegno, la guerra civile, i bombardamenti che, per la prima volta, non risparmiano le città, la guerra che termina solo per chi muore, la guerra che continua, che è sempre presente, che non cessa con la fine del romanzo, il quale termina alle soglie del suo ultimo difficile inverno.
Definita da Calvino questa conclusione «un’intuizione poetica che non solo serve a lasciare aperta la vicenda di Corrado, ma che ne allarga il senso».
Corrado, all’osteria sulla collina detta Alle Fontane incontra molti sfollati, giovani e vecchi, tra i quali Cate, donna che lui ha amato in gioventù, che ha abbandonato ingiustamente, allora debole e dipendente da lui, oggi forte sia per la sua capacità di impegno antifascista sia perché madre di un ragazzo che potrebbe essere suo figlio, quel figlio che impersona ciò che lui avrebbe potuto essere e che lui sente tale, che vede tale, di cui vorrebbe occuparsi e che invece perderà e senza poter avere quella conferma che gli darebbe un senso, perché Cate cadrà prigioniera in una retata tesa dai tedeschi. E Dino, il ragazzo, preso dalla smania della guerra, dell’azione, scapperà via e si perderà nel nulla, come nel nulla si perderà la speranza di Corrado di uscire dalla prigione della sua inettitudine.
Si è scritto da più parti che, terminata la lettura di un’opera di Pavese, resta poco nella mente della trama, difficilmente rintracciabile, forse perché non è importante in se stessa o perché è simile a quella di tutte le altre opere o perché naufraga in un mare di idee, di simboli, di descrizioni. Questa osservazione che, a nostro avviso, è inoppugnabile, sta a dimostrare da un lato che la trama è per Pavese solo un pretesto, un punto di partenza per raccontare delle idee, dall’altra che sul presunto realismo dell’autore c’è ancora molto da discutere. È innegabile la tendenza di Pavese a narrare se stesso, il suo dramma di uomo inetto, incapace di agire, di scegliere, di operare, tutto teso ad osservare la vita che gli scorre addosso e lo isola dalla possibilità di interagire con il mondo, quel dramma che alla fine lo porterà a scegliere il suicidio, ad anteporre la morte alla vita, ad andarsene da quel mondo che non sapeva entrare nella sua anima, se non come un paesaggio contemplato, come una meditazione illuminata dalla luce della luna o dal rosso di mille emblematici falò.
Pavese, dunque, quasi tardo-decadente, é impegnato a scavare in sé, a vivisezionarsi spietatamente, a cercare la sua strada, a compenetrarsi con la natura fatta di luna, di vigne, di stelle e di campagna. Non si può negare tutto questo, leggendo La casa in collina: le fughe, i rifugi, gli interrogativi, il suo rapporto con Dio, con la paternità mai realizzatasi ma disperatamente agognata e qui vissuta nel rapporto con Dino, che non è solo il figlio che potrebbe essere suo, ma è il figlio che potrebbe essere altro da lui, quell’altro lui, quello che ha il coraggio di scappare dal rifugio, di buttarsi nella mischia, di viverla la guerra, anche a costo di morire. No, non si può negare questo aspetto ma, a nostro avviso, non si può neanche negare l’oggettività del racconto, quella meditazione che parte da se stessa per essere allargata all’intera umanità, che non si interroga, ma forse dovrebbe farlo, sulla nefandezza di un evento che «(…) ci brucia le case. Ci semina di morti fucilati piazze e strade. Ci caccia come lepri di rifugio in rifugio. Finirà per costringerci a combattere anche noi, per strapparci un consenso attivo».
Proprio questa forza di rappresentazione oggettiva, che risulta vittoriosa sul dramma esistenziale soggettivo, permette al romanzo di resistere al tempo: Corrado è simbolo dell’individuo, l’uomo comune che non ha più la pretesa di poter influire sul corso della storia, che si vergogna di questa abominevole esperienza che uccide, che mette gli uni contro gli altri gli stessi italiani, che deve espiare (la sosta nella chiesa di Corrado in fuga è il culmine di tale ricerca di catarsi) e che solo grazie alla speranza di un rinnovamento dell’uomo può sopportare la vista di tutti quei morti che appaiono quasi la concretizzazione della colpa, dell’efferatezza, della bestialità.
Viene da sé che, oggettività a parte, il lettore resta incantato dalla capacità di Pavese di ritrarre il paesaggio, di utilizzare un linguaggio straordinariamente accattivante che, abbandonato il parlato dei primi romanzi, rimane comunque antiletterario, fatto di una sintassi utilizzata in modo “libero”, di ampie e variegate figure retoriche che immettono dentro alle parole, specchio di immagini, a loro volta specchio di una natura che ha ancora il coraggio e la forza di incantare, con quella luna che appare e scompare, che resta sospesa sulle vigne, che disegna un percorso, un itinerario spirituale, antidoto bianco e smagliante all’orrore della devastazione, al rosso del sangue, al verde opaco del rame che resta l’unico attestato di quelle che una volta erano vigne e profumo di campagna.
Pavese non si nega alla descrizione di se stesso quale anti-eroe, che rifiuta un ruolo attivo nella guerra, che fugge, che cerca riparo in una chiesa, in un convento, protagonista e osservatore della sua fuga attraverso i campi, tra desolazione e stupore, tra scene di morti che, siano neri siano rossi, è solo morte e soprattutto morte civile. Un anti-eroe che si sente condannato a questo ruolo, che forse invidia coloro che sono morti, perché per loro c’è stato un senso, per loro la guerra sarà finita, avrà avuto una sua collocazione spazio-temporale, avrà avuto un senso, sarà stata una vicenda storica, forse sbagliata, forse assurda ma reale. Per lui la guerra non cesserà mai.
Si legga l’amara constatazione delle ultime pagine, quando ormai giunto al suo ultimo rifugio, al termine della sua fuga reale e simbolica, mentre ancora da qualche parte si combatte, lui ha ripreso le sue passeggiate per la brulla campagna che circonda la sua casa: «Ripenso alla lunga illusione da cui ha preso le mosse questo racconto della mia vita. Dove questa illusione mi porti, ci penso sovente in questi giorni: a che altro pensare? (…). Che c’è di comune tra me e quest’uomo che è sfuggito alle bombe, sfuggito ai tedeschi, sfuggito ai rimorsi e al dolore? Non è che non provi una stretta se penso a chi è scomparso, se penso agli incubi che corrono le strade come cagne (…), ma accade che l’io, quell’io che mi vede rovistare con cautela i visi e le smanie di questi ultimi tempi, si sente un altro, si sente staccato, come se tutto ciò che ha fatto, detto e subito, gli fosse soltanto accaduto davanti- faccenda altrui, storia trascorsa».
Cesare/Corrado si interroga sul senso di tutti quei morti e si risponde che non saprebbe trovarlo ed è convinto che nessuno saprebbe, solo gli stessi morti, solo loro, gli unici forse a sapere perché tutto sia stato quel ch’è stato, e gli unici per i quali tutto è veramente finito. Per i vivi la realtà continua a essere una falce spietata, un frammento d’oscurità che nasconde la bellezza della luna, un freddo glaciale che corrode le energie e le speranze, un luogo desolato da cui fuggire non per viltà ma, per dirla ancora come Calvino, come farebbe «l’ombra d’un pellegrino buddista sugli altopiani indocinesi, tra i crateri di una guerra interminabile».