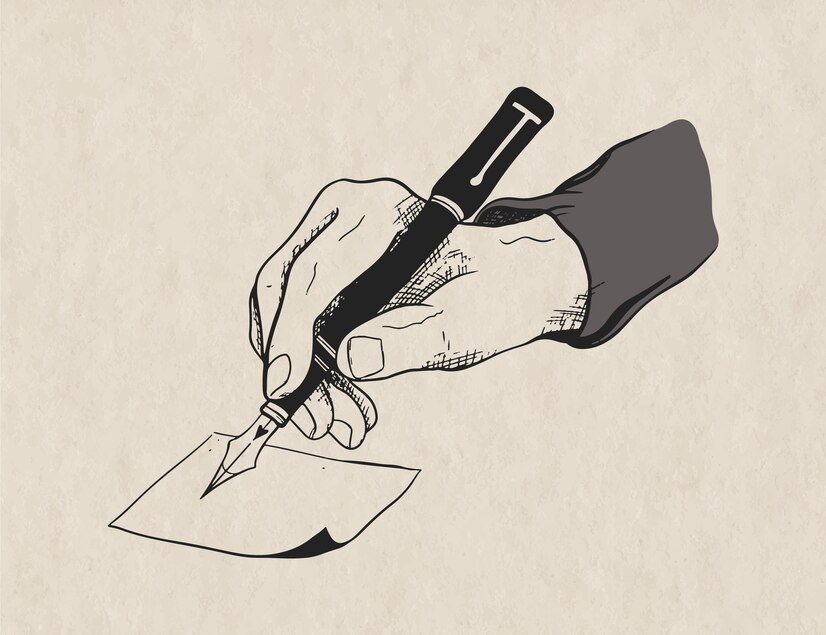Du « miracle économique » à la crise de la fin des années Soixante, « Il Menabò » couvre la période du « welfare state » en Italie.
Son principal animateur, Elio Vittorini, à partir d'une analyse de la crise de la culture italienne, propose comme objectif une littérature adhérant à son temps, une littérature qui tienne compte de la mutation introduite par l'industrialisation dans la Nature, y compris dans la nature humaine. Ce qui implique que cette adéquation se fasse au plan du travail sur l'écriture. Mais, dans le même temps, « Il Menabò » prolonge, dans la logique de l'idéologie de « I’engagement », la conception d'une littérature dont la fonction serait de « représenter », la représentation ayant d'emblée une signification, et pourquoi pas une portée transformatrice ou révolutionnaire.
«Il Menabò» nasce nel giugno 1959 a Torino mentre a Torino si stanno costruendo gli edifici della Mostra « Italia ‘61 » e a Roma si preparano le Olimpladi del ‘60 ; Livio Berruti si allena per conquistare la medaglia d’oro dei cento metri. Sempre in quegli anni, si sta avviando il processo che porterà a ciò che è stato il « centro-sinistra ». Si ha un'impressione complessiva di una specie di euforia, come se l’Italia fosse davvero diventata l’Italia del miracolo, della 600, di Mario Riva e, già, di Mike Bongiorno, del consenso sociale.
La carriera del « Menabò » si conclude col decimo numero, nell'aprile 1967, pochi mesi prima del ‘68 e dell''autunno caldo ».
Queste osservazioni preliminari per suggerire che, forse, non basta dire che « il Menabò » nasce nei primi anni del « miracolo economico italiano ».
Nasce più esattamente in un momento in cui, dopo la « ricostruzione », diventa possibile – o sembra possibile – una gestione riformista della crescita economica. E scompare proprio nel momento in cui questo tipo di sviluppo della formazione sociale italiana – non solo dell' economia – entra nella fase acuta della propria crisi.
Si può dunque dire che « il Menabò » vive esattamente gli anni del welfare state in Italia.
A questo punto devo, seppur brevemente, ricordare cose ormai risapute
ma che credo sia necessario tener presenti. Il periodo in cui nasce « Il Menabò » è quello dello sviluppo spettacolare di alcuni settori industriali (chimica, elettrodomestici, automobile), di trasformazioni dell'ambiente in una frenesia di autostrade, di urbanizzazione, di cemento armato e di speculazione edilizia. Nella vita culturale, alcune trasformazioni mostrano che, in questo campo, si sono aperte – o scoperte – nuove possibilità di profitto con l'industrializzazione della cultura, le pubblicazioni a puntate, ma anche con l'apparire delle grosse tirature aperto dal caso Lampedusa. È anche questo il periodo in cui comincia una funzione nuova dei mass-media, in campo culturale, ideologico e politico, con i primi sviluppi della televisione.
Ma questo sviluppo economico, queste trasformazioni della società, quello che ho chiamato l'apparente euforia, nascondono – ma forse no – il fatto che il loro movente essenziale è lo sviluppo del profitto finanziario e, dunque, che sono trasformazioni disuguali, disorganiche, che lasciano indietro i settori poco redditizi : trasporti pubblici, educazione, salute pubblica. Creano nuovi scompensi nella società italiana, particolarmente tra il Nord ed il Sud, spopolato dall'emigrazione verso le fabbriche del « triangolo industriale ».
Inoltre, conviene ricordare che, quando si parla dell'Italia degli anni Cinquanta e degli inizi degli anni Sessanta, si parla anche d'un paese in cui permangono gravi elementi di arretratezza del costume, un paese in cui non esiste il divorzio (non parliamo nemmeno dell'aborto legale). È dell'anno precedente la nascita del « Menabò » il clamoroso episodio del vescovo di Prato che, dal pulpito, chiamò « pubblici concubini » due persone che non si erano sposate in chiesa.
D'altra parte, ho parlato di gestione riformista della crescita economica.
Non bisogna però dimenticare che esistono delle forze che non rinunciano all'idea di una gestione autoritaria della società. Mi basti rammentare il tentativo del governo Tambroni nell’estate del '60 per opporsi al movimento antifascista.
Infine, ma non è di poco conto, questo sviluppo economico avviene in un sistema fondato sui bassi salari e sull’autorità assoluta del datore di lavoro nell'azienda.
In questo rapidissimo panorama, ho voluto sottolineare insieme gli elementi di un certo tipo di dinamica ma anche quelli che entreranno in crisi nel decennio che si apre quasi contemporaneamente alla pubblicazione del « Menabò ».
La crisi ha inizio ben presto: nel 1963, la crescita economica comincia a rallentare; il governatore della Banca d'Italia chiede il contenimento della spesa pubblica e quello dei salari. Nello stesso anno, la costituzione del primo governo di centro-sinistra avviene sulla base d'un indebolimento delle forze che lo compongono. Nel ‘64, i servizi segreti del SIFAR progettano un golpe.
Dell’euforia della fine degli anni Cinquanta, qualcosa traspare probabilimente nel « Menabò », fosse solo in quella specie di modernismo e di entusiasmo industrialofilo, proprio non solo di Vittorini ma di tutta o quasi la redazione e che, ovviamente, si esprime più che altro nei numeri 4 e 5 della rivista.
Non c'è da parlarne in modo ironico e nemmeno polemico. C’è, da parte dell’équipe di Vittorini e Calvino, la scoperta e la dimostrazione che ciò che cambia nellleconomia e nella società italiana ha una dimensione qualitativa: sono elementi nuovi che non si aggiungono ad una natura pre-esistente ma modificano tale natura, compresa la stessa natura umana. In questo modo, « il Menabò » dà il proprio contributo, forse determinante, alla trasformazione del mondo culturale italiano, alla nascita della letteratura dell'industria e interviene nella già lunga storia della letteratura itallana dell'alienazione.
L'intento scoperto della rivista, quale viene presentato dall'introduzione al primo numero, è quello di avere i caratteri sia d'una rivista che di una collana letteraria: « i testi di letteratura creativa che vi andremo pubblicando (di narrativa, di poesia, di teatro) saranno tutti così lunghi che ciascuno di essi dovrebbe poter fare libro a sè ed essere comunque in grado di dare un'idea completa della personalità (al momento) di chi lo ha scritto […] ogni testo avrà accanto (oltre a note informative o polemiche) un saggio critico concertato in sede di direzione che tratti del problema morale o storico o letterario cui il testo in qualche modo, per dritto o per rovescio, si riferisce.
Questo per cercare di vedere a che punto ci troviamo nelle varie, troppe, questioni non solo letterarie oggi in sospeso, e per cercare di capire come si potrebbe rimetterci in movimento ».
L'obiettivo è duplice. « Il Menabò » si propone di fare il punto sulla situazione della letteratura italiana e di contribuire al suo rilancio. Uno scopo forse meno ambizioso di quello del «Politecnico» che si proponeva di rinnovare la totalità della vita culturale e, per suo tramite, della vita sociale. Adesso, Vittorini, cui si è ormai affiancato Calvino, tenta – il titolo di « Menabò» sembra sia anche un'indicazione in tal senso – di costituire una guida per l’insieme del fenomeno letterario, scrittori, lettori, editoria, ma per il solo campo letterario.
Vittorini prende lo spunto da quella che chiama, sempre nella stessa introduzione al numero 1, « la crisi della letteratura (e, in genere, della cultura), in Italia ».
Non interessa, per questa relazione, entrare nel merito di questo discorso. Vorrei solo sottolineare che Vittorini parla di rimettere in movimento la letteratura italiana, il che significa che secondo lui, si è arrestata. Poi, parla di « crisi ». Ora, sarebbero da controllare due punti:
1) se « crisi » significhi necessariamente « stasi »
2) se vi sia realmente in Italia tale crisi (o stasi) culturale.
Queste due questioni non riguardano però direttamente ciò che intendo trattare; va solo notato che il punto di partenza del « Menabò » è la crisi, o stasi, della letteratura italiana.
Nei primi numeri della rivista, Vittorini e Calvino si dilungano su questa crisi e sulle sue cause, in una prospettiva che chiamerei, approssimativamente, sociologica e ideologica. Nel primo numero, Vittorini caratterizza tale crisi come « deficienza critica » e ne elenca le cause « serie e profonde » :
1) livellamento delle esperienze della cultura umanistica attraverso le manifestazioni della cultura di massa […]
2) accelerato ‘sviluppo’ in senso verticale della cultura scientifica e della tecnica […]
3) « decadenza » dell'individuo come soggetto di auto-determinazione ideologica e insomma come eroe […]
Cause serie e profonde d'una deficienza critica che, notiamolo en passant, corrispondono agli obbiettivi che erano stati quelli della letteratura «impegnata » degli anni 45-55, del « Politecnico », dello stesso Vittorini : cultura di massa, cultura scientifica e tecnica, decadenza dell’eroe.
Ma la causa più grave per Vittorini è « il fenomeno purtroppo così immobile e irreversibile, così negativo […] dell'avanguardismo moderno ». La condanna della neo-avanguardia da parte di Vittorini (ma fu una condanna reciproca) include anche la beat-generation americana e, in un primo tempo, il nouveau roman, l'école du regard, « Tel quel » in Francia. Da questo punto di vista, le cose cambieranno, particolarmente col « Menabò 4 ».
L'analisi fatta da Calvino nel Mare dell’oggettività (« .Menabò 2 », febbraio ‘60) coincide ampiamente con questa critica di Vittorini. L'articolo inizia così :
« I romanzi della 'école du regard' raccontati attraverso gli oggetti […] Da una cultura basata sul rapporto e contrasto tra due termini, da una parte la coscienza la volontà il giudizio individuali e dall'altra il mondo oggettivo, stiamo passando o siamo passati a una cultura in cui quel primo termine è sommerso dal mare dell’oggettività, dal flusso ininterrotto di ciò che esiste ».
Già nella figura di Gurdulù, il servo del Cavaliere inesistente pubblicato nel ‘59, quel servo tanto estroverso da trasformarsi in ciò che egli vede, c’era la polemica contro questa tendenza a « l'identificazione con l’esterno, con la totalità esistenziale indifferenziata dall’io ». E nel « Menabò 2 », Calvino conclude appellandosi invece ad una « letteratura della coscienza ».
Però, a questo tipo di analisi della crisi della letteratura, riferita a comportamenti o modelli culturali, subentra un'altra critica, di tipo « storia della cultura », fondata sulla crisi specifica, italiana, del neo-realismo. Nel numero 4 (settembre ‘61) della rivista, consacrato ai rapporti tra letteratura e industria, mi sembra alquanto chiaro l’attacco da parte di Vittorini contro un atteggiamento di tipo neorealistico: « i narrativi, lungi dal trarre un qualunque vantaggio di novità di sguardo (e di giudizio) dalla nuova materia che trattano, sembrano invece trovarsene talmente impacciati che si comportano, dinanzi ad essa come se fosse un semplice settore nuovo d'una più vasta realtà già risaputa e non un nuovo grado, un nuovo livello dell'insieme della realtà umana : riducendosi con ciò a darne degli squarci pateticamente (e pittorescamente) descrittivi che risultano di sostanza naturalistica ».
E le parole « naturalismo », « realismo », « neo-realismo », « verismo », assumono regolarmente un significato, poco differenziato, negativo, di « antiletterario » e di « reazionario », il che è chiaramente una rottura con le impostazioni, talvolta degli stessi scrittori, dieci o quindici anni prima, quando la parola « realismo » significava volontà trasformatrice e progressiva, volontà di contatto con la realtà e quindi con il popolo.
Calvino scrive nella Sfida al labirinto (« Menabò 5 », luglio ‘62):
« La letteratura che si propone di rappresentare criticamente i primi aspetti dell'industrialismo nasce da questa couche borghese così compromessa, e ne eredita molti atteggiamenti. La condanna estetico-ideologica che pesa oggi su di essa è stata confermata si può dire unanimamente dai giurati delle più diverse tendenze critiche. Per limitarci al romanzo francese nel periodo compreso tra George Sand e Zola, si salvano i due meno compromessi con l’ideologia umanitaria del tempo, Stendhal e Balzac ( … ) mentre cade Victor Hugo. E cade Zola che si documenta sulle miniere e sulle halles ».
Raffaele Crovi nel numero 6 (settembre ‘63) afferma che i poeti neo-realisti « scambiarono per epica popolare un antilirico racconto populistico » e tratta con grande ironia tale populismo e operaismo. Nel N.5, Franco Fortini, in polemica esplicita con Lukàcs, contesta il posto e la funzione privilegiati del romanzo nella nostra epoca mentre Franceso Leonetti rifiuta il rapporto tra la letteratura e l’ideologia. Anche queste sono posizioni polemiche rispetto al neo-realismo e al dibattito sul realismo negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Non per niente, nel N.7 (marzo 1964), Angelo Romanò considera chiuso il discorso sul realismo quale è stato portato avanti dopo la guerra.
Naturalmente, si potrebbe giudicare normale, sano, che si voglia negli anni ‘60, andare oltre un dibattito degli anni ‘40. Ma il problema non è questo : per la redazione del « Menabò », come per tanti altri intellettuali del tempo, non si tratta di pagina voltata, si tratta di pagina sbagliata.
Senza andare per ora in cerca dei motivi profondi, di tipo, secondo me, ideologico-storico, di questo rifiuto radicale del neo-realismo, che coinvolge la stessa nozione di realismo, prenderò adesso lo spunto dalla critica formulata da Mario Spinella nel numero 9 (giugno 1965): « Il discorso neorealista era sostanzialmente un discorso composito, culturale più che letterario, impregnato di volontà sociologica, storica, politica ».
Lo scopo della rivista viene cosi precisato. Non si tratta più solo di rilancio della letteratura. Si tratta di tentare una definizione o ridefinizione del compito della letteratura. Non la politica, non la sociologia, non la storia, e nemmeno la cultura. Vittorini aveva già anticipato la risposta del «Menabò» nel N.4: il compito della letteratura è la letteratura. In questo senso vanno appunto intese la domanda: « a qual punto le ‘cose nuove’ tra cui oggi viviamo, direttamente o indirettamente [hanno] un riscontro di ‘novità ‘ nell'immaginazione umana », e l'affermazione : « chiunque racconti di fabbriche e aziende lo [fa] sempre entro del limiti letterariamente ‘preindustriali’ ». La questione per Vittorini non è di parlare di fabbriche o d'industria, ma di fare una letteratura del tempo delle fabbriche e dell'industria.
Rientra dunque nel progetto della rivista il portare avanti la riflessione sui problemi, non più del compito della letteratura, come ai tempi del « Politecnico », ma della teoria della letteratura. In parole povere : che cos’è la letteratura?
Così, Umberto Eco, nel N.5, pubblica un articolo (Del modo di formare come impegno sulla realtà) centrato sull’idea che l’impegno dell'opera letteraria è l’impegno formale:
« […] l’accettazione di una data struttura narrativa presuppone l'accettazione di una certa persuasione dell'ordine del mondo rispecchiato dal linguaggio che uso […].
Nel momento in cui l’artista si accorge che il sistema comunicativo é estraneo alla situazione storica di cui vuole parlare, deve decidere che non sarà attraverso l’esemplificazione di un soggetto storico che egli potrà esprimere la situazione, ma solo attraverso l’assunzione, l'invenzione, di strutture formali che si facciano il modello di questa situazione.
Il vero contenuto dell'opera diventa il suo modo di vedere il mondo e di giudicarlo, risolto in modo di formare, e a questo livello andrà condotto il discorso sui rapporti tra l’arte e il proprio mondo ».
Michele Rago, nell'ultimo numero, dedicato a Vittorini (morto l’anno precedente), ricorda che «Vittorini, in letteratura, è stato ai suoi tempi, il più attento ai mutamenti formali. Si è definito, fino all'ultimo, un formalista».
Nel N.5, Fortini avverte il pericolo di tale ritorno alla forma. Non un astratto pericolo del formalismo, ma il pericolo che si consideri che, nel quadro di un reale pressoché immutabile, la letteratura abbia una funzione prefissa in un settore ben limitato. Potrei dire che Fortini teme una letteratura da welfare state, dimentica che « gli uomini sono divisi in classe » e « che le strutture economiche sono né più né meno che l’inconscio sociale ».
Ma questa polemica fondamentale resta marginale per « il Menabò ». E la questione della letteratura come attività formale occupa un posto di rilievo nella rivista. Di conseguenza, viene posta con insistenza la questione della lingua. Una delle critiche che Mario Spinella rivolgeva al neo-realismo era proprio « la mancanza di ogni seria ricerca sul terreno che è proprio della letteratura : la lingua e l’uso della lingua ». (« Menabò 8 »).
Fin dal primo numero, Michele Rago, con un articolo su La ragione dialettale, osserva che la lingua « non è puramente strumentale ». Nel N.2, Vittorini, che aveva anche scritto un breve appunto nel N.1 su Parlano le metafore, torna sul tema dei rapporti tra lingua e dialetto. Fin qui, però, siamo in una problematica così banale, per l’Italia, che lascia il tempo che trova.
Gianluigi Bragantin nel N.5, invece, si colloca in una problematica ben più vicina a quella esposta da Vittorini, sui rapporti tra letteratura e industria: « è vero che non può esservi una modificazione qualitativa nelle vocazioni, negli impegni della letteratura senza una contemporanea modificazione del suo linguaggio ».
Però, sono soprattutto gli interventi di Calvino e Umberto Eco a tentare impostazioni nuove sull'argomento nel N.5. Eco espone la strategia di una nuova letteratura : « non c’é che da portare a chiarezza l'alienazione : estraniandola, oggettivandola in una forma che la riproduca ». Calvino è più prudente : « il concetto di linguaggio va considerato, nella sua accezione letteraria più estensiva, come metodo di rappresentazione della propria visione del mondo ».
Non è il caso di tentare una conclusione su quella discussione.
Discussione incompiuta, tra l’altro. Si può solo osservare che, nel tentativo di rilanciare la letteratura italiana, la redazione e i collaboratori del « Menabò » sono coinvolti in un dibattito sui rapporti tra letteratura, lingua e ideologia, che non è loro proprio ma si svolge su scala anche internazionale. Ma è un dibattito che non propone alla cultura, alla letteratura, di svolgere una funzione trasformatrice del reale. Propone, invece, di attenersi al reale, di essere all'altezza delle trasformazioni, non di suscitarle o di contribuirvi.
Nello stesso tempo, però, « il Menabò » – collaboratori e redattori – continua a portare avanti – o a trascinarsi dietro – schemi e criteri che sanno di anni ‘40 e soprattutto ‘50 : per esempio, l’idea di una letteratura la cui funzione sia quella di rappresentare, con la premessa che i fatti parlano da sè. Raffaele Crovi, nel « Menabò 3 » rimprovera alla letteratura meridionalista di non aver saputo rappresentare analiticamente o globalmente, la realtà. Nel N.5, Bragantin critica una letteratura « incapace di rappresentare il significato degli inauditi camblamenti di cui è testimone ».
Nello stesso modo, buona parte della discussione nei numeri 4 e 5 rimane fuori tema rispetto alle domande fatte da Vittorini. Le risposte vertono soprattutto sulla funzione dell'intellettuale, sul suo rapporto all'ideologia, ecc… non su che cosa stia diventando, o debba diventare, la letteratura. Calvino, nel N.2, nella sua polemica contro « il mare dell'oggettività », ritrova accenti degni del « Politecnico » : « la tensione ideale s’è logorata ( … ), è la crisi dello spirito rivoluzionario.
Rivoluzionario è chi non accetta il dato naturale e storico e vuole cambiarlo ».
Sicché, nell'analisi delle cause della crisi della letteratura, sembra che ci sia anche e forse soprattutto l'affievolirsi dell' « engagement » che è stato così connaturale al neo-realismo, quello stesso neo-realismo tanto deprecato.
Questa ambiguità, o questa contraddizione, spiega anche un’altra contraddizione. Mentre si avvia verso la ricerca di una teoria della letteratura, « il Menabò » funziona in gran parte sul terreno della storia e della sociologia della cultura. Calvino e Vittorini, nell'analisi della crisi della letteratura, sono sensibili a ciò che sta avvenendo. Ma lo sono altrettanto a quello che è avvenuto delle speranze – o illusioni – e dei tentativi, nati con l’antifascismo, la Resistenza, la Liberazione, e ricacciati indietro dalla rottura dell'unità antifascista da parte della D.C. e dalla guerra fredda. Poi, « l’indimenticabile ‘56 », così vicino alla nascita del « Menabò », ha trasformato in miti superati per molti intellettuali queste speranze già appassite. In questo senso, se « il Menabò » è, in parte, una rivista del welfare state, è anche una rivista della « generazione degli anni difficili ».
Pierre LAROCHE