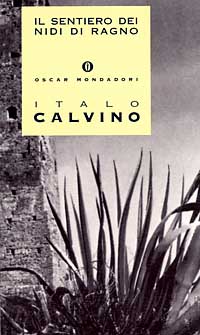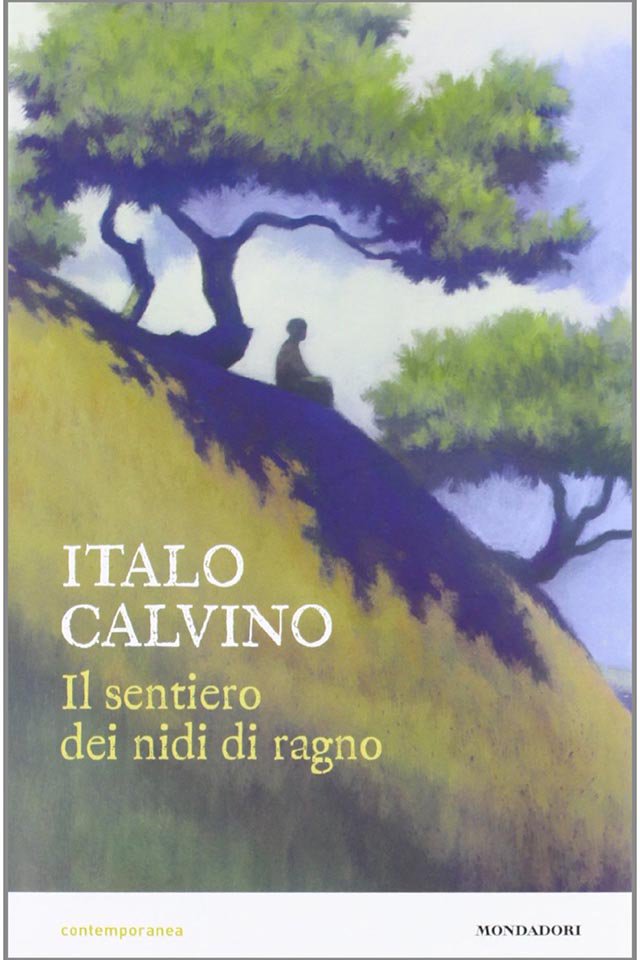La trilogia degli antenati
Dopo l’esperienza narrativa del Sentiero dei nidi di ragno (1947), che aveva risolto l’impellenza della realtà storica della Resistenza nella dimensione avventurosa e quasi favolistica del giovane Pin, Calvino abbandona l’interesse per la storia recente e punta il suo sguardo sull’uomo contemporaneo. E fa ciò attraverso un approccio più analitico, che ne metta a nudo, sotto forma metaforica e allegorico-fantastica, crisi e turbamenti, contraddizioni e riflusso di speranze storiche, sociali e politiche, incompletezze, scissioni della coscienza, contrapposizioni tra intelligenza e volontà, opposizioni irriducibili. L’obiettivo di Calvino, dagli anni ’50 in poi non è tanto quello di riproporre una rappresentazione della realtà attraverso le vicende di personaggi in essa comunque inseriti, ma piuttosto di affrontare la dimensione psicologico – esistenziale dell’uomo con una tensione analitica, capace di dar vita ad una inedita ricerca espressiva, orientata da un interesse etico per la sorte della nascente società dei consumi, apparentemente deprivata di ideali e di coerenza negli atteggiamenti.
La Trilogia degli antenati – formata in successione da Il visconte dimezzato ( 1952 ), Il barone rampante (1957) , Il cavaliere inesistente (1959) – propone ambientazioni storico-favolistiche, che, attraverso vicende surreali e paradossali, affrontano il tema del doppio, della scissione della personalità. Non è senza significato che queste storie vadano a recuperare – liberamente riorganizzati dalla fantasia narrativa – contesti legati al passato. Calvino ha bisogno del filtro straniante del tempo storico, che gli consente di costruire con grande profondità il suo discorso sull’uomo contemporaneo, attraverso allegorie originalissime. E ciò senza vincolarlo ad una rappresentazione troppo facilmente decodificabile del presente. La favola che guarda indietro nel tempo, proietta del resto analisi acute e verità ancor più nitide sull’uomo contemporaneo.
ll visconte dimezzato
E’ la parabola della duplicità apparentemente inconciliabile. Il visconte Medardo sullo sfondo delle Crociate parte per la guerra e viene colpito da una palla di cannone che salva solo una metà della sua persona. Si tratta purtroppo della metà cattiva. Tornato a casa sottopone il suo feudo a incredibili vessazioni. Tutto dai funghi, alle pere, agli insetti al suo passaggio viene tagliato in due. Un giorno però anche l’altro mezzo visconte torna a casa, altrettanto insopportabile nella sua totale bontà: mieloso, invadente, caritatevole.. a dimostrare che gli eccessi si toccano con il comune denominatore dell’eccesso. Il visconte per un caso fortuito ripristinerà la sua unità, supererà il doppio e riconquisterà l’armonia, assorbendo in parti eguali bontà e cattiveria, bene e male. La proposta è quella di un concetto di umanità intesa come equilibrio. Ma è la narrazione che sfrutta ottimamente la struttura bi-focale dell’intera storia: alla consequenzialità tradizionale, corrisponde la frantumazione della linea d’azione che si diparte in tante prospettive diverse di intervento sul reale.
Il barone rampante
Ambientato nel Settecento presso una dimora della nobiltà ligure, la vicenda ripropone una nuova biforcazione della realtà: il piano orizzontale della vita, che quotidianamente si sviluppa nella piccola corte settecentesca e quello verticale della vita sugli alberi, organizzata dal giovane Conte Cosimo Piovasco del Rondò, che abbandona la famiglia e le noiose abitudini del suo ceto sociale, per socializzare con le creature del bosco e stringere un patto di solidarietà con tutto ciò che è alternativo. La trasgressione è questa volta irreversibile ed equivale ad una scelta di vita. L’anticonformismo del protagonista dà voce alla dimensione utopica della personalità umana, che consente di osservare con maggiore lucidità l’esistente, da una prospettiva privilegiata di sospensione e distacco.
Il cavaliere inesistente
A completare la trilogia degli antenati, ne Il cavaliere inesistente l’opposizione si fa sempre più irriducibile. Il conte di Carlo Magno Agilulfo è in realtà armatura vuota, che pure esiste per forza della sola volontà ( è cioè una forma di inesistenza munita di coscienza ) , mentre il suo doppio lo scudiero Gurdulù, corpaccione dai mille nomi, è pronto ad immedesimarsi in ogni aspetto del reale, perché vive ma non sa di essere ( è cioè esistenza priva di coscienza ). La lacerazione tra le due nature dell’uomo ( la volontà enfatica e la coscienza del cavaliere, sempre pronto a servire una causa, e la pura fisicità anonima e deprivata di ogni valore dello scudiero Gurdulù ) riporta simbolicamente alla critica di Calvino per la cancellazione del ruolo del soggetto nella società di massa.
La trilogia degli antenati – da Il Cavaliere inesistente
Agilulfo
– E voi? – Il re era giunto di fronte a un cavaliere dall’armatura tutta bianca; solo una righina nera correva torno torno ai bordi; per il resto era candida, ben tenuta, senza un graffio, ben rifinita in ogni giunto, sormontata sull’elmo da un pennacchio di chissà che razza orientale di gallo, cangiante d’ogni colore dell’iride. Sullo scudo c’era disegnato uno stemma tra due lembi d’un ampio manto drappeggiato, e dentro lo stemma s’aprivano altri due lembi di manto con in mezzo uno stemma più piccolo, che conteneva un altro stemma ammantato più piccolo ancora. Con disegno sempre più sottile era raffigurato un seguito di manti che si schiudevano uno dentro l’altro, e in mezzo ci doveva essere chissà che cosa, ma non si riusciva a scorgere, tanto il disegno diventava minuto. – E voi lì, messo su così in pulito… – disse Carlomagno che, più la guerra durava, meno rispetto della pulizia nei paladini gli capitava di vedere.
– Io sono, – la voce giungeva metallica da dentro l’elmo chiuso, come fosse non una gola ma la stessa lamiera dell’armatura a vibrare, e con un lieve rimbombo d’eco, – Agilulfo Emo Bertrandino dei Guildiverni e degli Altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia Citeriore e Fez!
– Aaah… – fece Carlomagno e dal labbro di sotto, sporto avanti, gli uscì anche un piccolo strombettio, come a dire: «Dovessi ricordarmi il nome di tutti, starei fresco! » Ma subito aggrottò le ciglia. – E perché non alzate la celata e non mostrate il vostro viso?
Il cavaliere non fece nessun gesto; la sua destra inguantata d’una ferrea e ben connessa manopola si serrò più forte all’arcione, mentre l’altro braccio, che reggeva lo scudo, parve scosso come da un brivido.
– Dico a voi, ehi, paladino! – insisté Carlomagno. – Com’è che non mostrate la faccia al vostro re? La voce uscì netta dal barbazzale. – Perché io non esisto, sire
– O questa poi! – esclamò l’imperatore. – Adesso ci abbiamo in forza anche un cavaliere che non esiste! Fate un po’ vedere.
Agilulfo parve ancora esitare un momento, poi con mano ferma ma lenta sollevò la celata. L’elmo era vuoto. Nell’armatura bianca dall’iridescente cimiero non c’era dentro nessuno.
– Mah, mah! Quante se ne vedono! – fece Carlomagno. – E com’è che fate a prestar servizio, se non ci siete?
– Con la forza di volontà, – disse Agilulfo, – e la fede nella nostra santa causa!
– E già, e già, ben detto, è così che si fa il proprio dovere. Be’, per essere uno che non esiste, siete in gamba!
Agilulfo era il serrafila. L’imperatore ormai aveva passato la rivista a tutti; voltò il cavallo e s’allontanò verso le tende reali. Era vecchio, e tendeva ad allontanare dalla mente le questioni complicate.
La tromba suonò il segnale del « rompete le righe ». Ci fu il solito sbandarsi di cavalli, e il gran bosco delle lance si piegò, si mosse a onde come un campo di grano quando passa il vento. I cavalieri scendevano di sella, muovevano le gambe per sgranchirsi, gli scudieri portavano via i cavalli per la briglia. Poi, dall’accozzaglia e il polverone si staccarono i paladini, aggruppati in capannelli svettanti di cimieri colorati, a dar sfogo alla forzata immobilità di quelle ore in scherzi ed in bravate, in pettegolezzi di donne e onori.
Agilulfo fece qualche passo per mischiarsi a uno di questi capannelli, poi senz’alcun motivo passò a un altro, ma non si fece largo e nessuno badò a lui. Restò un po’ indeciso dietro le spalle di questo o di quello, senza partecipare ai loro dialoghi, poi si mise in disparte. Era l’imbrunire; sul cimiero le piume iridate ora parevano tutte d’un unico indistinto colore; ma l’armatura bianca spiccava isolata lì sul prato. Agilulfo, come se tutt’a un tratto si sentisse nudo, ebbe il gesto d’incrociare le braccia e stringersi le spalle.
Poi si riscosse e, di gran passo, si diresse verso gli stallaggi. Giunto là, trovò che il governo dei cavalli non veniva compiuto secondo le regole, sgridò gli staffieri, inflisse punizioni ai mozzi, ispezionò tutti i turni di corvé, ridistribuì le mansioni spiegando minuziosamente a ciascuno come andavano eseguite e facendosi ripetere quel che aveva detto per vedere se avevano capito bene. E siccome ogni momento venivano a galla le negligenze nel servizio dei colleghi ufficiali paladini, li chiamava a uno a uno, sottraendoli alle dolci conversazioni oziose della sera, e contestava con discrezione ma con ferma esattezza le loro mancanze, e li obbligava uno ad andare di picchetto, uno di scolta, l’altro giù di pattuglia, e così via. Aveva sempre ragione, e i paladini non potevano sottrarsi, ma non nascondevano il loro malcontento. Agilulfo Emo Bertrandino dei Guildiverni e degli Altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia Citeriore e Fez era certo un modello di soldato; ma a tutti loro era antipatico.
Gurdulù
Carlomagno cavalcava alla testa dell’esercito dei Franchi. Erano in marcia d’avvicinamento; non c’era fretta; non s’andava tanto svelti. Attorno all’imperatore facevano gruppo i paladini, frenando per il morso gli impetuosi cavalli; e in quel caracollare e dar di gomito i loro argentei scudi s’alzavano e s’abbassavano come branchie d’un pesce. A un lungo pesce tutto scaglie somigliava l’esercito: a un’anguilla. Contadini, pastori, borghigiani accorrevano ai bordi della strada. – Quello è il re, quello è Carlo! – e s’inchinavano giù a terra, ravvisandolo, più che dalla poco familiare corona, dalla barba. Poi subito si tiravano su per riconoscere i guerrieri: – Quello è Orlando! Ma no, quello è Ulivieri! – Non ne imbroccavano uno ma tanto era lo esso, perché questo o quell’altro lì c’erano tutti e potevano sempre giurare d’aver visto chi volevano.
Agilulfo, cavalcando nel gruppo, ogni tanto spiccava una piccola corsa avanti, poi i fermava ad aspettare gli altri, si girava indietro a controllare che la truppa seguisse compatta, o si voltava verso il sole come calcolando dall’altezza sull’orizzonte l’ora. Era impaziente.
Lui solo, lì in mezzo, aveva in mente l’ordine di marcia, le tappe, il luogo al quale dovevano arrivare avanti notte. Quegli altri paladini, ma sì, marcia d’avvicinamento, dar forte o andar piano è sempre avvicinarsi, e con la scusa che l’imperatore è vecchio e stanco a ogni taverna erano pronti a fermarsi per bere. Altro per via non vedevano che insegne di taverne e deretani di serve, tanto per dire quattro impertinenze; per resto, viaggiavano come chiusi in un baule.
Carlomagno era ancora quello che provava più curiosità per tutte le specie di cose che si vedevano in giro. – Uh, le anatre, le anatre! – esclamava. Ne andava, per i prati ungo la strada, un branco. In mezzo a quelle anatre, era un uomo, ma non si capiva osa diavolo facesse: camminava accoccolato, le mani dietro la schiena, alzando i piedi i piatto come un palmipede, col collo teso, e dicendo: – Quà… quà… quà… – Le anatre non gli badavano nemmeno, come se lo riconoscessero per uno di loro. E a dire vero, tra l’uomo e le anatre lo sguardo non faceva gran distacco, perché la roba che aveva indosso l’uomo, d’un colore bruno terroso (pareva messa insieme, in gran parte, ori pezzi di sacco), presentava larghe zone d’un grigio verdastro preciso alle loro pene, e in più c’erano toppe e brandelli e macchie dei più vari colori, come le striature ridate di quei volatili.
– Ehi, tu, ti par questa la maniera d’inchinarti all’imperatore? – gli gridarono i paladini, sempre pronti a grattar rogne.
L’uomo non si voltò, ma le anatre, spaventate da quelle voci, frullarono su a volo tutte insieme. L’uomo tardò un momento a guardarle levarsi, naso all’aria, poi aperse le braccia, spiccò un salto, e così spiccando salti e starnazzando con le braccia spalancate da cui pendevano frange di sbrindellature, dando in risate e in «Quàaa! Quàaa! » pieni di gioia, cercava di seguire il branco.
C’era uno stagno. Le anatre volando andarono a posarsi lì a fior d’acqua e, leggere, ad ali chiuse, filarono via nuotando. L’uomo, allo stagno, si buttò sull’acqua giù di pancia, sollevò enormi spruzzi, s’agitò con gesti incomposti, provò ancora un «Quà! Quà! » che fini in un gorgoglio perché stava andando a fondo, riemerse, provò a nuotare, riaffondò.
– Ma è il guardiano delle anatre, quello? – chiesero i guerrieri a una contadinotta che se ne veniva con una canna in mano.
– No, le anatre le guardo io, son mie, lui non c’ent ra, è Gurdulù… – disse la contadinotta.
– E che faceva con le tue anatre?
– Oh niente, ogni tanto gli piglia così, le vede, si sbaglia, crede d’esser lui…
– Crede d’essere anatra anche lui?
– Crede d’essere lui le anatre… Sapete com’è fatto Gurdulù: non sta attento…
– Ma dov’è andato, adesso?
I paladini s’avvicinarono allo stagno. Gurdulù non si vedeva. Le anatre, traversato lo specchio d’ acqua avevano ripreso il cammino tra l’erba con i loro passi palmati. Attorno allo stagno, dalle felci, si levava un coro di rane. L’uomo tirò fuori la testa dall’acqua tutt’a un tratto, come ricordandosi in quel momento che doveva respirare. Si guardò smarrito, come non comprendendo cosa fosse quel bordo di felci che si specchiavano nell’acqua a un palmo dal suo naso. Su ogni foglia di felce era seduta una piccola bestia verde, liscia liscia, che lo guardava e faceva con tutta la sua forza: Gra! Gra! Gra!
– Gra! Gral Gral – rispose Gurdulù, contento, e alla sua voce da tutte le felci era un saltar giù di rane in acqua e dall’acqua un saltar di rane a riva, e Gurdulù gridando:
– Gra! – spiccò un salto anche lui, fu a riva, fradicio e fangoso dalla testa ai piedi, s’accoccolò come una rana, e gridò un – Grai – così forte che in uno schianto di canne ed erbe ricadde nello stagno.
– Ma non ci annega! – chiesero i paladini a un pescatore.
– Eh, alle volte Omobòl si dimentica, si perde… Annegare no… Il guaio è quando finisce nella rete con i pesci… Un giorno gli è successo mentre s’era messo lui a pescare… Butta in acqua la rete, vede un pesce che è lì lì per entrarci, e s’immedesima tanto di quel pesce che si tuffa in acqua ed entra nella rete lui… Sapete com’è, Omobò…
– Omobò? Ma non si chiama Gurdulù?
– Omobò, lo chiamiamo noi.
– Ma quella ragazza…
– Ah, quella non è del mio paese, può darsi che al suo lo chiamino così.
– E lui di che paese è?
– Be’, gira…
La cavalcata fiancheggiava un frutteto di peri. 1 frutti erano maturi. Con le lance i guerrieri infilzavano pere, le facevano sparire nel becco degli elmi, poi sputavano i torsoli. In fila in mezzo ai peri, chi vedono? Gurdulù-Omobò. Stava con le braccia alzate tutte contorte, come rami, e nelle mani e in bocca e sulla testa e negli strappi del vestito aveva pere.
– Guardalo che fa il pero’ – diceva Carlomagno, ilare.
– Ora lo scuoto! – disse Orlando, e gli menò una botta.
Gurdulù lasciò cadere le pere tutte insieme, che rotolarono per il prato in declivio, e vedendole rotolare non seppe trattenersi dal rotolare anche lui come una pera per i prati e sparì così alla loro vista.
Vostra maestà lo perdoni! – disse un vecchio ortolano. – Martinzùl non capisce alle volte che il suo posto non è tra le piante o tra i frutti inanimati, ma tra i devoti sudditi di vostra maestà!
– Ma cos’è che gli gira, a questo matto che voi chiamate Martinzùl? – chiese, bonario, il nostro imperatore. – Mi pare che non sa manco cosa gli passa nella crapa!
– Che possiamo capirne noi, maestà? – Il vecchio ortolano parlava con la modesaggezza di chi ne ha viste tante.
Matto forse non lo si può dire: è soltanto uno che c’è ma non sa d’esserci.
– O bella! Questo suddito qui che c’è ma non sa d’esserci e quel mio paladino là sa d’esserci e invece non c’è. Fanno un bel paio, ve lo dico io!
Di stare in sella, Carlomagno era ormai stanco. Appoggiandosi ai suoi staffieri, andò nella barba, bofonchiando: – Povera Francia! – smontò. Come a un segnale, appena l’imperatore ebbe messo piede a terra, tutto l’esercito si fermò e allestì un bivacco. Misero su le marmitte per il rancio.
– Portatemi qui quel Gurgur… Come si chiama? – fece il re.
– A seconda dei paesi che attraversa, – disse il saggio ortolano, – e degli eserciti criiani o infedeli cui s’accoda, lo chiamano Gurdurù o Gudi-Ussuf o Ben-Va-Ussuf o en-Stanbùl o Pestanzùl o Bertinzùl o Martinbon o Omobon o Omobestia oppure anche il Brutto del Vallone o Gian Paciasso o Pier Paciugo. Può capitare che in una cascina sperduta gli diano un nome del tutto diverso dagli altri; ho poi notato che dappertutto i suoi nomi cambiano da una stagione all’altra. Si direbbe che i nomi gli scorrano addosso senza mai riuscire ad appiccicarglisi. Per lui, tanto, comunque lo si chiami è stesso. Chiamate lui e lui crede che chiamiate una capra; dite «formaggio» o « torte » e lui risponde: « Sono qui ».
Due paladini – Sansonetto e Dudone – venivano avanti trascinando di peso Gurdulù come fosse un sacco. Lo misero in piedi a spintoni davanti a Carlomagno. – Scopriti il capo, bestia! Non vedi che sei davanti al re!
La faccia di Gurdulù s’illuminò; era una larga faccia accaldata in cui si mischiavano caratteri franchi e moreschi: una picchiettatura di efelidi rosse su una pelle olivastra; occhi celesti liquidi venati di sangue sopra un naso camuso e una boccaccia dalle labbra umide; pelo biondiccio ma crespo e una barba ispida a chiazze. E in mezzo a questo pelo, impigliati, ricci di castagna e spighe d’avena.
Cominciò a prosternarsi in riverenze e a parlare fitto fitto. Quei nobili signori, che finora l’avevano sentito emettere solo versi d’animali, si stupirono. Parlava molto in fretta, mangiandosi le parole e ingarbugliandosi; alle volte sembrava passare senz’interruzione da un dialetto all’altro e pure da una lingua all’altra, sia cristiana che mora. Tra parole che non si capivano e spropositi, il suo discorso era pressapoco questo:
Tocco il naso con la terra, casco in piedi ai vostri ginocchi, mi dichiaro augusto servitore della vostra umilissima maestà, comandatevi e mi obbedirò! – Brandì un cucchiaio che portava legato alla cintura. – … E quando la maestà vostra dice: «Ordino comano e voglio », e fa così con lo scettro, così con lo scettro come faccio io, vedete?, e grida sì come grido io: « Ordinooo comandooo e vogliooo! » voialtri tutti sudditi cani dovete obbedirmi se no vi faccio impalare e tu per primo lì con quella barba e quella faccia da vecchio rimbambito!
– Debbo tagliargli la testa di netto, sire? – chiese Orlando, e già snudava.
– Impetro grazia per lui, maestà, – disse l’ortolano. – E’ stata una delle sue sviste solite: parlando al re s’è confuso e non s’è più ricordato se il re era lui o quello a cui parlava.
Dalle marmitte fumanti veniva odor di rancio.
– Dategli una gavettata di zuppa! – disse, clemente, Carlomagno.
Con smorfie, inchini e incomprensibili discorsi, Gurdulù si ritirò sotto un albero a mangiare.
– Ma che fa, adesso?
Stava cacciando il capo dentro alla gavetta posata in terra, con il capo dentro la gavetta posata in terra come volesse entrarci dentro.
Il buon ortolano andò a scuoterlo per una spalla. – Quando la vuoi capire, Martinzùl, che sei tu che devi mangiare la zuppa e non la zuppa che deve mangiare te!
Non ti ricordi? Devi portartela alla bocca col cucchiaio…
Gurdulù cominciò a cacciarsi in bocca cucchiaiate, avido. Avventava il cucchiaio con tanta foga che alle volte sbagliava mira. Nell’albero al cui piede era seduto s’apriva una cavità, proprio all’altezza della sua testa. Gurdulù prese a buttare cucchiaiate di zuppa nel cavo del tronco.
– Non è la tua bocca, quella! E’ dell’albero!
Agilulfo aveva seguito fin da principio con un’attenzione mista a turbamento le mosse di questo corpaccione carnoso, che pareva rotolarsi in mezzo alle cose esistenti soddisfatto come un puledro che vuol grattarsi la schiena; e ne provava una specie di vertigine. – Cavalier Agilulfo! – fece Carlomagno. – Sapete cosa vi dico? Vi assegno quell’uomo lì come scudiero! Eh? Neh che è una bella idea?
I paladini, ironici, ghignavano. Agilulfo che invece prendeva sul serio tutto (e tanto più un espresso ordine imperiale!), si rivolse al nuovo scudiero per impartirgli i primi comandi, ma Gurdulù, trangugiata la zuppa, era caduto addormentato all’ombra di quell’albero. Steso nell’erba, russava a bocca aperta, e petto stomaco e ventre s’alzavano e abbassavano come il mantice d’un fabbro. La gavetta unta era rotolata vicino a uno dei suoi grossi piedi scalzi. Di tra l’erba, un porcospino, forse attratto dall’odore, s’avvicinò alla gavetta e si mise a leccare le ultime gocce di zuppa. Così facendo spingeva gli aculei contro la nuda pianta del piede di Gurdulù e più andava avanti risalendo l’esiguo rigagnolo di zuppa più premeva le sue spine nel piede nudo. Finché il vagabondo non aperse gli occhi: girò lo sguardo intorno, senza capire da dove veniva quella sensazione di dolore che l’aveva svegliato. Vide il piede nudo, dritto in mezzo all’erba come una pala di fico d’India e, contro il piede, il riccio.
– O piede, – prese a dire Gurdulù, – piede, ehi, dico a te! Cosa fai piantato lì come uno scemo? Non lo vedi che quella bestia ti spuncica? O piedeee! O stupido! Perché non ti tiri in qua? Non senti che ti fa male? Scemo d’un piede! Basta tanto poco, basta che ti sposti di tanto così! Ma come si fa a essere così stupidi! Piedeee! E stammi a sentire! Ma guarda un po’ come si lascia massacrare E tirati in qua, idiota! Come te l’ho da dire? Sta attento: guarda come faccio io, ora ti mostro cosa devi fare… – E così dicendo piegò la gamba, tirando il piede a sé e allontanandolo dal porcospino. Ecco: era tanto facile, appena t’ho mostrato come si fa ce l’hai fatta anche tu. Stupido piede, perché sei rimasto tanto a farti pungere?
Si strofinò la pianta indolenzita, saltò su, si mise a fischiettare, spiccò una corsa, si gettò attraverso i cespugli, mollò un peto, poi un altro, poi sparì.